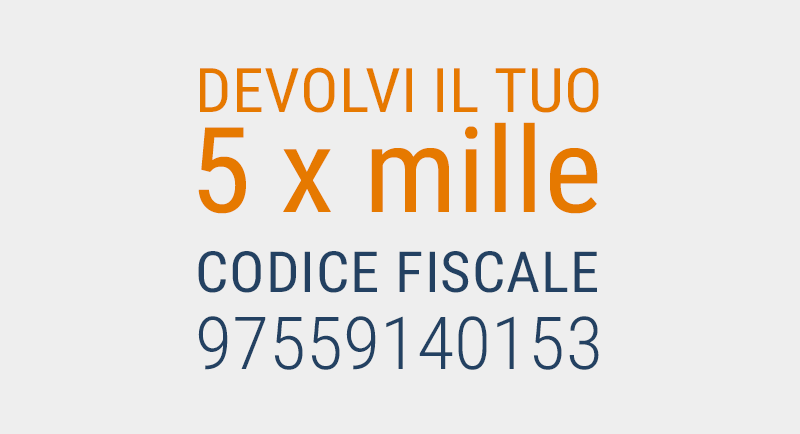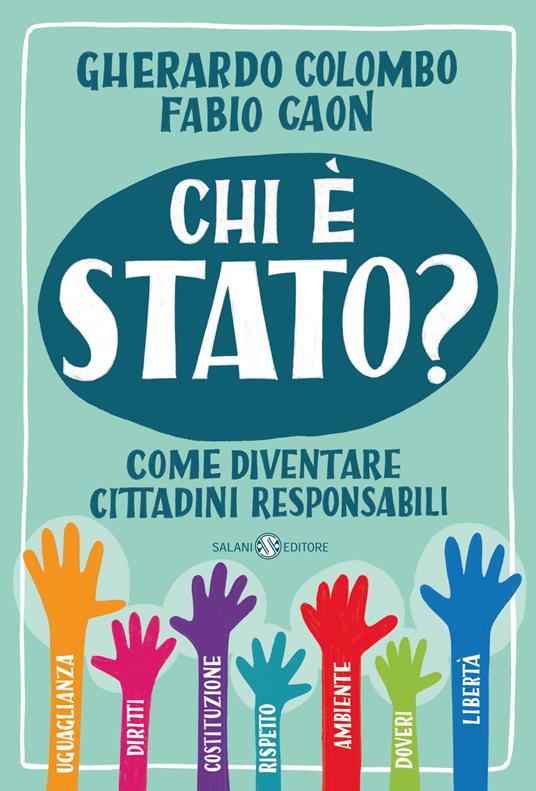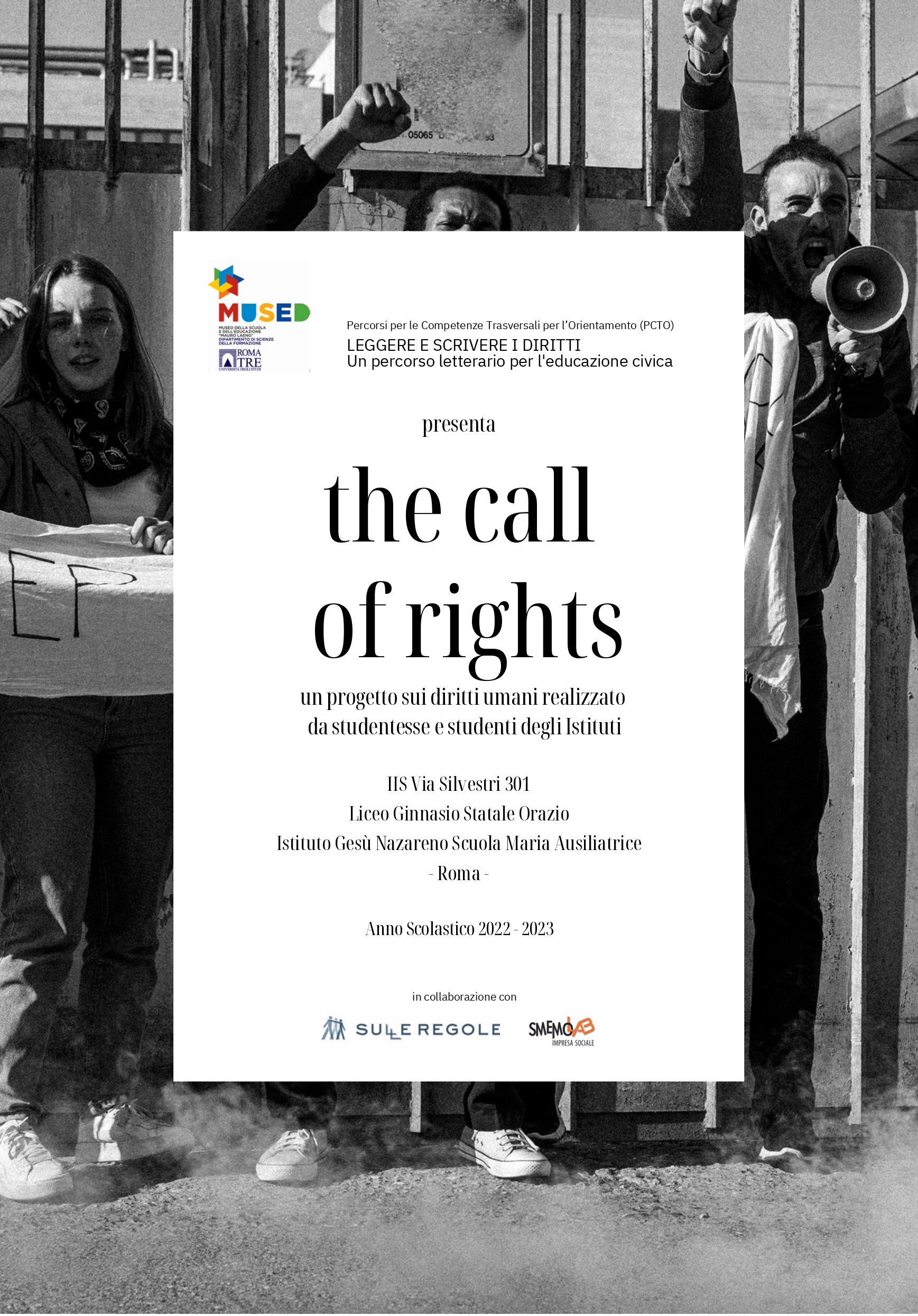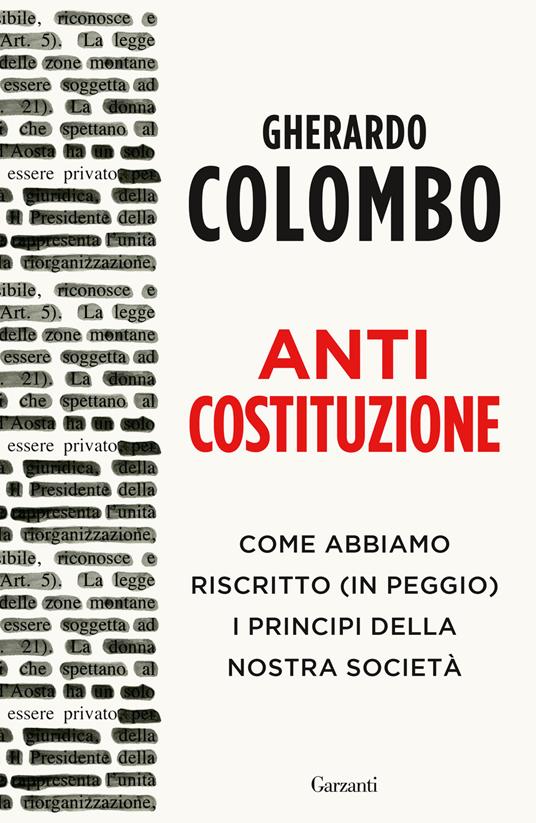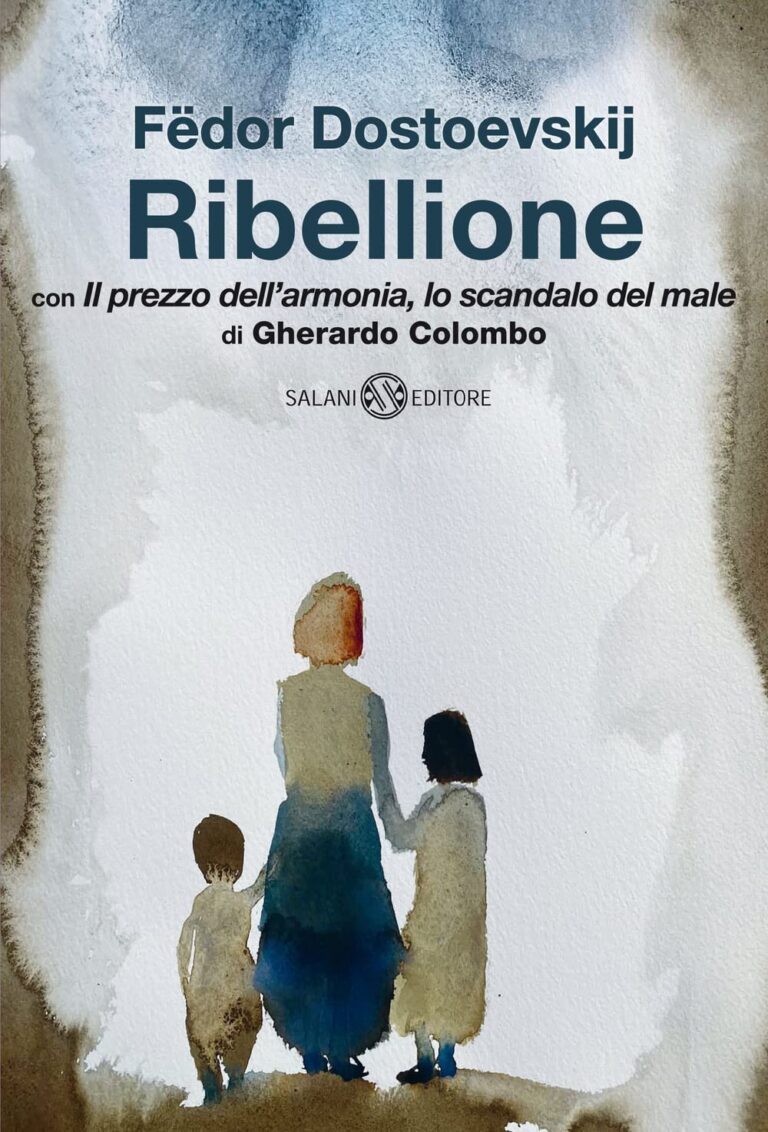Italia 1964
142 minuti
La vita del Cristo secondo uno dei tre evangelisti sinottici da cui, però, sono stati espunti tutti i passi escatologici e la maggior parte dei miracoli. È un film laico, rivolto a mettere in luce l’umanità più che la divinità di un Gesù severo, pugnace, medievale, carico di tristezza e di solitudine. Quando il regista riesce a far coincidere il testo di Matteo con l’autobiografia, la passione con l’ideologia, è il film di un poeta. In senso teologico, è un vangelo senza speranza. Con il suo sincretismo formale, i riferimenti pittorici, la scabra luminosità, il richiamo a un Terzo Mondo che non è più solo preistoria, raggiunge una forte tonalità epica e religiosa. Dedicato “alla cara, lieta e familiare memoria di Giovanni XXIII”. Premio speciale della giuria e altri 3 collaterali, tra cui quello dell’OCIC (cattolico) a Venezia; 3 Nastri d’argento 1965 (regia, fotografia, costumi). Insulti beceri di neofascisti e cattolici in camicia nera. Fotografia: Tonino Delli Colli. Scene: Luigi Scaccianoce. Costumi: Danilo Donati. Il catalano Irazoqui doppiato da E.M. Salerno.
“Ad un anno di distanza dall’episodio La ricotta, che costò a Pier Paolo Pasolini l’accusa di vilipendio alla religione, apparve alla Mostra di Venezia, e poi nelle sale italiane, Il vangelo secondo Matteo. Era il 1964, e il film fu accolto dall’allora Papa Giovanni XXIII, al quale l’opera è dedicata, e dal mondo cattolico, con grande attenzione. Per quella sua disarmante bellezza, per quel suo taglio poetico e per quel suo silenzioso respiro mistico, capace com’è di produrre una sorta di stordimento.” – Cristina Borsatti – Avvenire.
“Tentato dal Vangelo di Matteo, di cui ci aveva anticipato tramite Bach alcune vibrazioni nella colonna musicale di Accattone, Pasolini si è preoccupato di darne un’interpretazione canonica. Come ormai tutti sanno il suo film è stato girato in Italia: c’è una sovrapposizione del meridione sulla Palestina, di Matera su Gerusalemme, delle plebi cavernicole di ieri su quelle di oggi. Pasolini è partito dai “maggi” e dalle sacre rappresentazioni popolari, ma vi ha sommato tutta la sua vasta e sicura conoscenza figurativa, il suo amore per il “pastiche” culturale. ” – Tullio Kezich – Il Corriere della Sera